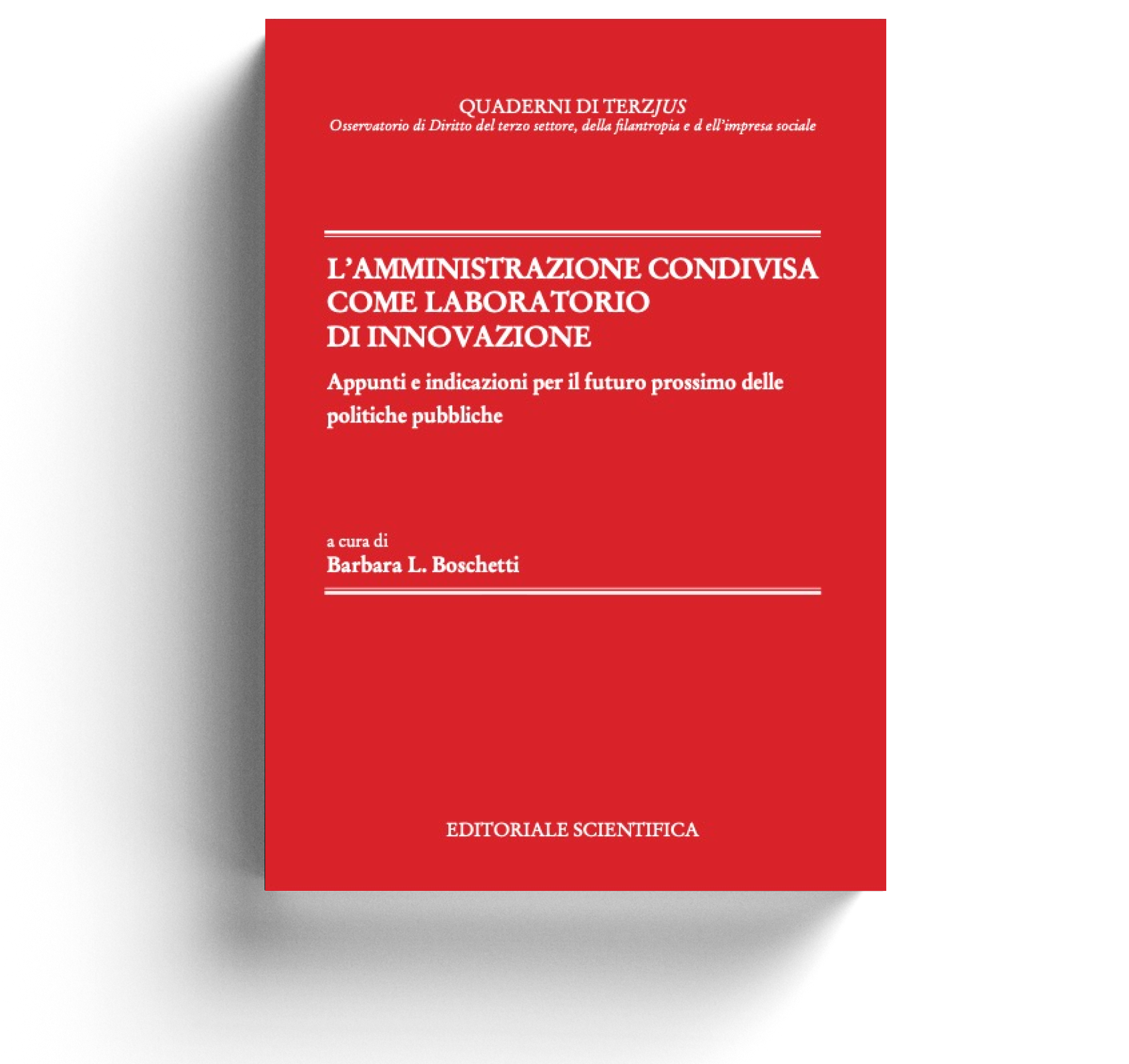La presentazione del quaderno di Terzjus intitolato “L’amministrazione condivisa come laboratorio di innovazione – Appunti e indicazioni per il futuro prossimo delle politiche pubbliche” a cura di Barbara L. Boschetti oltre a suscitare profondo interesse ha stimolato osservazioni e riflessioni di giovani al Sud e di comunità locali che, già, coltivano esperienze di questo genere perché ci credono fortemente.
L’amministrazione condivisa è partecipazione, è collaborazione e chiama a ruoli ed interlocuzioni, anche, i giovani. Donato Ciao, è un giovane Founder & Innovation Designer presso GRUV – Design for impact, si occupa di innovazione e ci porta la sua riflessione. “Quando parliamo di partecipazione giovanile, soprattutto in un paese della provincia del Sud Italia, il rischio di adottare approcci paternalistici è, sempre, dietro l’angolo. Si continua a vedere le nuove generazioni come destinatari di politiche, come soggetti da includere, da coinvolgere, da educare alla cittadinanza. Eppure, la realtà che viviamo in provincia e nei contesti periferici ci racconta altro. Racconta di giovani-adulti che già abitano responsabilità e sfide complesse, che cercano spazi dove esercitare autonomia, che chiedono di essere riconosciuti, di contribuire alla trasformazione sociale dello spazio pubblico e di co-costruire il futuro prossimo delle politiche pubbliche. A dirla in breve non chiedono più di fare per loro, ma con loro”.
Questo cambio di prospettiva è cruciale e richiama al “contesto culturale” nel contributo di Felice Scalvini che riflette circa le cause della difficoltà per l’amministrazione condivisa ad affermarsi come modello ordinario e strutturale nei rapporti tra PA ed ETS. Un richiamo forte e sentito, soprattutto, in un paese della provincia del Sud dove, forse, il vero e proprio cambio di paradigma stenta a maturare pur in presenza di un tessuto giovanile fertile che si contraddistingue per nuove figure professionali e per una prospettiva di medio/lungo periodo che interesserà, certamente, i giovani.
In questo contesto culturale, bisogna rimuovere sedimenti politici quali elementi o influenze che, spesso, influenzano le dinamiche e i comportamenti politici. Questi sedimenti possono essere di natura diversa, come gli interessi economici, le culture politiche, le identità sociali e le strategie elettorali, che accumulatisi, hanno un impatto sulle politiche pubbliche.
Riprendendo alcuni passaggi del contributo di Luciano Gallo: l’amministrazione condivisa si sostanzia in un diverso “volto” dell’agire amministrativo, una “forma” della stessa PA e della sua attività, riconducibile non già alle forme tradizionali di amministrazione attiva, quanto piuttosto come declinazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Ancora Luciano Gallo: in questa prospettiva tutte le amministrazioni pubbliche sono parte di questo cambiamento, secondo latitudini e intensità anche diverse e discendenti dalla corrispondente “intenzionalità politica” con la conseguenza che occorre comprendere correttamente in che modo l’AC “entra” strutturalmente dentro le PA.
Non vi è alcun dubbio, al riguardo, che l’AC si realizzi mediante procedimenti amministrativi, disciplinati dalla legge 241/1990, ma è parimenti chiaro che questi ultimi siano strumentali ad una forma “innovativa” di collaborazione con ETS e per la cura dei bisogni della comunità. Eppure, ci dice Donato che, tuttavia, la distanza dagli epicentri del potere e dai grandi centri decisionali non è necessariamente un limite anzi, al contrario, può diventare occasione per attivare nuove energie, riscrivere alleanze locali, immaginare modelli di governance condivisa non come replica di pratiche metropolitane, ma come espressione autentica ed originale dei territori.
L’amministrazione condivisa, come sostiene Marocchi nel quaderno di Terzjus, non sia procedimento ma sia processo di costruzione di un capitale fiduciario e di relazioni senza il quale non si realizza l’esperienza collaborativa.
È necessario l’esercizio di un’opzione politica netta e decisa a favore di un processo trasformativo, politico e culturale. Una pratica che chiama in causa l’equilibrio tra interessi (inter esse: “essere tra”) e ridefinisce il significato dell’agire pubblico, in chiave relazionale e rigenerativa.
Questa rivoluzione copernicana, continua Donato, può e deve partire dalla provincia, ma per essere concreta ha bisogno di spazi di possibilità (non solo fisici), intesi come luoghi ibridi di relazione e progettazione, dove possano nascere nuove identità civiche e forme inedite di collaborazione; linguaggi (non solo istituzionali) vale a dire codici comuni che abilitino un dialogo orizzontale tra pubblica amministrazione, enti del Terzo Settore e comunità giovanili; di pratiche e rituali intesi come dispositivi leggeri, ripetibili e generativi, che alimentino il protagonismo sociale e rafforzino fiducia, agentività e corresponsabilità.
L’esperienza che stiamo maturando in provincia di Salerno ed, in particolare a Eboli, ci conferma che la collaborazione non si impone, si coltiva. Richiede ascolto profondo, capacità di mediazione, competenze di design, facilitazione e soprattutto cura delle relazioni.
Sulla sponda della PA, a livello territoriale, c’è bisogno di un capitale umano e politico capace di recepire gli appunti e le indicazioni per il futuro prossimo delle politiche pubbliche.