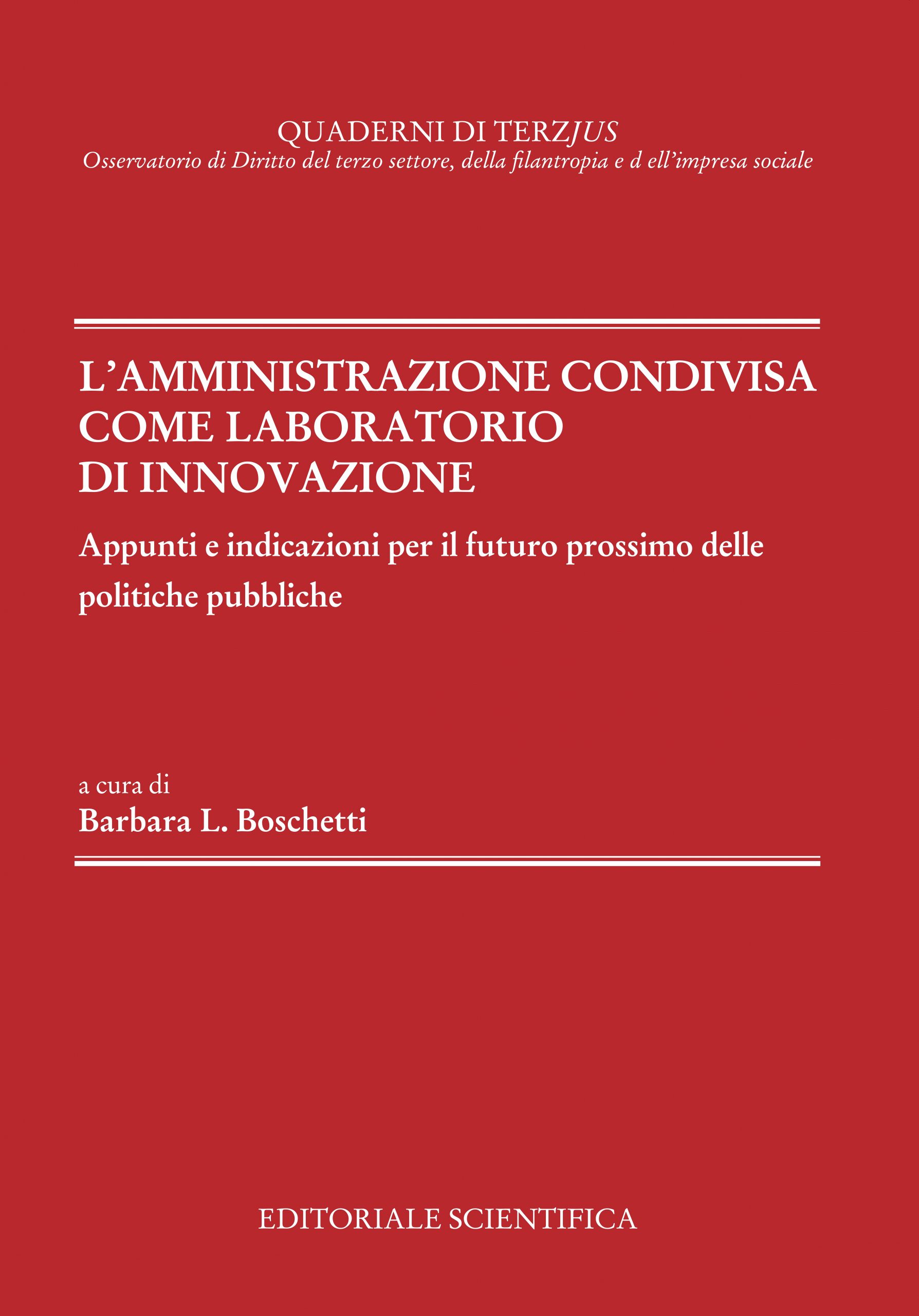[di Luigi Bobba, introduzione al volume L’amministrazione condivisa come laboratorio di innovazione. Appunti indicazioni per il futuro prossimo delle politiche pubbliche, a cura di Barbara L. Boschetti, Editoriale scientifica, Napoli 2025]
Il titolo stesso di questo volume, edito nella collana “Quaderni” della Fondazione Terzjus – L’Amministrazione condivisa come laboratorio di innovazione – indica con chiarezza l’intento della curatrice Barbara Boschetti e della Fondazione.
Fin dalla sua nascita, la Fondazione ha dedicato infatti particolare attenzione al tema del Rapporto tra Pubblica Amministrazione (PA) ed Enti del Terzo Settore (ETS). Non a caso, il primo “Quaderno” di Terzjus – I Rapporti tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, Editoriale Scientifica, Napoli 2020 – era incentrato su questo tema con commenti e riflessioni a caldo sulla ben nota sentenza n.131/2020 della Corte costituzionale. Successivamente, alla fine del 2022, la Fondazione decideva di avviare un “Laboratorio dell’Amministrazione condivisa” (LAC) con l’obiettivo di monitorare, seppur in via sperimentale, l’attuazione dell’applicazione degli articoli 55, 56, 57 del Codice del terzo settore (CTSS); articoli con i quali si è procedimentalizzata l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale mediante gli istituti della programmazione, della coprogettazione e della convenzione. Da questo primo lavoro di ricerca a carattere multidisciplinare, nasceva un nuovo “Quaderno” dal titolo “Per un laboratorio dell’Amministrazione condivisa, Editoriale Scientifica Napoli, 2024, dove si dava conto sia di una prima ricognizione dello sviluppo del fenomeno, sia delle problematiche emergenti a fronte di un’applicazione della normativa ancora in non pochi casi faticosa e a volte contraddittoria. Da qui l’esigenza di un nuovo step di lavoro finalizzato a definire orientamenti, modelli e strumenti per una “buona” amministrazione condivisa. Il risultato, dopo più di un anno di lavoro, è quello che i lettori potranno trovare in questo Quaderno sempre curato da Barbara Boschetti. La composizione del team di ricerca riflette il carattere multidisciplinare del lavoro, in quanto sono presenti non solo giuristi ma anche scienziati sociali, dirigenti della PA e manager del Terzo settore. Proprio da questa molteplicità di competenze ed esperienze professionali, è nato uno studio che ha l’ambizione di contribuire a far sì che gli operatori sul campo – quadri della PA e quadri del terzo settore – possano trovare non solo ispirazione, ma anche indicazioni pratiche per meglio utilizzare gli innovativi istituti dell’Amministrazione condivisa (AC).
Il volume si articola in quattro parti e 12 capitoli nonché di una mappa/ manifesto finale. La prima parte – Il contesto culturale – si apre con un contributo di Felice Scalvini che riflette circa le cause della difficoltà per l’amministrazione condivisa ad affermarsi come modello ordinario e strutturale nei rapporti tra PA ed ETS. Per non mettere vino nuovo in otri vecchi – dice l’autore – servono sia un vero e proprio cambio di paradigma, ma anche un approccio corale, nuove figure professionali e un orizzonte di medio lungo periodo. Proseguendo nella traiettoria del cambio di paradigma, Marco Cau e Graziano Maino, guidano i lettori in tre essenziali percorsi volti a facilitare i processi dell’amministrazione condivisa e si spingono anche a indicare figure-tipo necessarie per questa facilitazione: gli imprenditori della collaborazione, i formatori-consulenti e gli animatori della partecipazione. Per concludere che l’AC può diventare un modello innovativo e promettente di cura e cogestione di interessi e beni pubblici. La prima parte si chiude con uno scritto di Antonio Fici ”Gratuità e comunione di scopo nell’amministrazione condivisa” che si inoltra su una questione alquanto controversa, oggetto di non poche pronunce della giurisprudenza amministrativa. Una lettura riduttiva del binomio non lucratività/gratuità rischia di essere una grossa pietra d’inciampo sulla strada di pratiche effettivamente collaborative tra Pubbliche Amministrazioni e ETS. Ma è nella “comunione di scopo” che si trova la chiave per superare questa strettoia.
La seconda parte – Il contesto delle organizzazioni pubbliche e private – si apre con un articolato contributo di Luciano Gallo che con un’efficace immagine – l’AC “volto” dell’ente pubblico e “ forma” della PA – indica con chiarezza la strada di percorrere. Se l’Amministrazione condivisa vuole diventare forma tipica degli enti pubblici, sono necessari sia deleghe politiche specifiche (assessori del terzo settore, consiglieri delegati), sia uffici dedicati nonché tracce evidenti negli atti programmatici dell’ente stesso (DUP, bilanci, regolamenti). Solo se l’AC entrerà intenzionalmente nella PA, ne potrà innervare la cultura e l’organizzazione. Infine Gallo propone dieci “comandamenti” per passare dalle affermazioni di principio al fare “buona” amministrazione condivisa. Patrick Vesan e Anna Fasoli approfondiscono poi uno dei temi sollevati da Gallo: l’AC come veicolo di cambiamento organizzativo. Lo fanno sia presentando i caratteri di un modello di cambiamento organizzativo (strutturale, processuale, culturale e capacitativo), sia applicando lo stesso a due casi esemplari: i Comuni di Bologna e Verona.
A partire dall’analisi qualitativa di questi due casi, gli autori provano ad avanzare alcune originali domande di ricerca su aree ancora inesplorate. Segue il saggio di Nicola Berti – Profili organizzativi dell’amministrazione condivisa – che parte da un’affermazione netta: l’AC non è solo un nuovo procedimento, ma una nuova organizzazione della PA. I cittadini non sono solo meri destinatari passivi del potere pubblico, ma centri attivi del perseguimento delle finalità sociali convergenti con quelle affidate alle competenze della PA. Lo sviluppo dell’AC non si regge solo sul principio di sussidiarietà, ma si avvale anche dei principi di omogeneità, responsabilità e unicità (tipici della PA) per favorire un coinvolgimento sinergico dei privati (non solo ETS) nell’AC. In quest’ottica, la PA non è un soggetto separato, ma esteso all’intera società come insieme di attori accomunati dall’impegno del perseguimento di interessi generali.
La terza parte – Il contesto delle politiche pubbliche – è aperta da un saggio di Gianfranco Marocchi dal titolo alquanto significativo = “Non solo procedimento, ma collaborazione”. La tesi dell’autore è che l’AC potrà affermarsi se si sposterà l’attenzione dalla procedura al processo, ovvero a ciò che accade prima, durante e dopo la formale emissione di un provvedimento. L’autore, volendo supportare l’azione, sia dell’operatore pubblico sia del terzo settore, indica con chiarezza i passi da compiere, gli ostacoli da superare, le figure professionali da mettere in campo, le risorse da attivare. Insomma una piccola ed efficace guida per costruire un capitale fiduciario senza il quale non si realizza l’esperienza collaborativa tra PA ed ETS. Marco Marucci, invece, conduce il lettore ad esplorare e a riconoscere – Gli altri strumenti dell’AC –: partenariati sociali pubblico-privato, patti di collaborazione, regolamenti di gestione dei beni comuni. Una rassegna che fa vedere come l’AC sia un fenomeno più ampio di quello riconducibile all’articolo 55 del CTS, ma interrelato con il Codice dei contratti pubblici, oltreché a non pochi casi di strumenti anche informali. Seguono due contributi, a firma rispettivamente di Cristiano Caltabiano e Luca Pesenti il primo, e di Gianluca Budano il secondo, dedicati a presentare e valutare casi di Amministrazione condivisa nel campo delle politiche del lavoro e delle politiche sociosanitarie. Caltabiano e Pesenti a loro volta, dopo una breve disamina della legislazione regionale circa l’utilizzo dell’AC nell’area dei servizi socio-sanitari, esplorano tre casi in diverse aree del paese – Friuli Venezia Giulia, Lazio e Puglia – di originali applicazioni di AC nell’attivazione di servizi socio sanitari rivolti in particolare a persone anziane interessate da patologie neurologiche (Alzheimer, ecc.) e bambini affetti da disturbi autistici. Ciò che risulta da questa disamina è l’importanza di coinvolgere nel servizio non solo il destinatario specifico (anziani e bambini) ma anche le famiglie e i caregiver; superare l’antica querelle tra sociale e sanitario; e creare una effettiva integrazione tra pubblico, privato e terzo settore. I tre casi esaminati dimostrano per un verso la difficoltà dell’amministrazione condivisa ad insediarsi anche nell’area della sanità in senso stretto; dall’altro l’adattabilità dell’AC a territori, bisogni e soggetti alquanto diversificati. Budano racconta un’esperienza di AC promossa dall’ARPAL Puglia (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro-) per manifestare al lettore quanto e come sia possibile coprogettare con il Terzo settore servizi per il lavoro in grado di superare non poche rigidità burocratiche e di raggiungere, proprio per l’apporto degli ETS, i soggetti più vulnerabili.
L’ultima parte – Il contesto della regolazione – consiste in due contributi rispettivamente di Francesco Severgnini e Giangiorgio Macdonald. Nel primo, Severgnini muove dall’affermazione che i regolamenti comunali siano già oggi la via più diffusa per l’applicazione del principio di sussidiarietà. Sono infatti più di 300 gli enti locali che hanno adottato regolamenti per la gestione di beni comuni. Questa larga diffusione fa dire all’autore che gli stessi sono diventati un vettore dell’AC e hanno trasformato l’autonomia regolamentare in una disciplina sistematica; non di meno, e’ ancora necessario formare e accompagnare le PA e il loro personale nella scoperta e sperimentazione di modelli e di prassi. Chiude questa quarta parte il contributo di Giangiorgio Macdonald che sviluppa il tema del rapporto tra amministrazione condivisa e Codice dei contratti pubblici (CCP). Il saggio muove dalla constatazione che, con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs 36/2023 – si rende esplicita l’autonomia paritaria tra la disciplina della contrattualistica pubblica e le forme dell’AC normate dal CTS, ovvero si supera, anche in legge ordinaria, la supremazia del CCP e, come aveva già fatto la Corte, si legittima un canale alternativo a quello del mercato e del profitto. Ciò avviene non solo nelle forme ordinarie dell’AC (articolo 55 del CTS), ma anche nei patti di collaborazione e ancor di più nel “partenariato sociale”, strumento che può essere utilizzato non solo con gli ETS, ma anche con i privati profit in ragione di una “convenienza” che trascende la sola dimensione economica per tener conto anche della dimensione solidaristica. Nella stessa direzione si muove anche il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali mediante il D.lgs. 210/2022, dove è espressamente previsto il coinvolgimento dei cittadini. In sintesi, conclude l’autore, il principio di concorrenza non è più egemone e la concorrenza nella AC si trasforma in “concorsualità”.
Chiude l’intero volume una mappa/manifesto elaborata della curatrice Barbara Boschetti – Una bussola per il futuro prossimo delle politiche pubbliche – che si presenta come una vera e propria guida operativa o meglio una bussola per orientarsi nei territori ancora in gran parte sconosciuti della AC. Davvero uno strumento di facile utilizzo per non perdersi nelle molteplici ma ancora incerte e non standardizzate forme di attuazione dell’AC.
In conclusione, non si può che formulare l’auspicio che la nomina (settembre 2024) del Comitato guida ministeriale dell’Osservatorio dell’amministrazione condivisa consenta di giungere rapidamente a realizzare un monitoraggio e un accompagnamento di quanto sta avvenendo in particolare negli enti locali e nelle Regioni. Ugualmente ci si attende che il MLPS dia continuità all’impegno formativo e consulenziale (avviato nel biennio 23/24) verso i quadri sia della PA sia del Terzo settore. Fondazione Terzjus, con il LAC, è pronta a mettere a disposizione un patrimonio di conoscenze e di pratiche al fine di contribuire a realizzare una “buona” amministrazione condivisa.