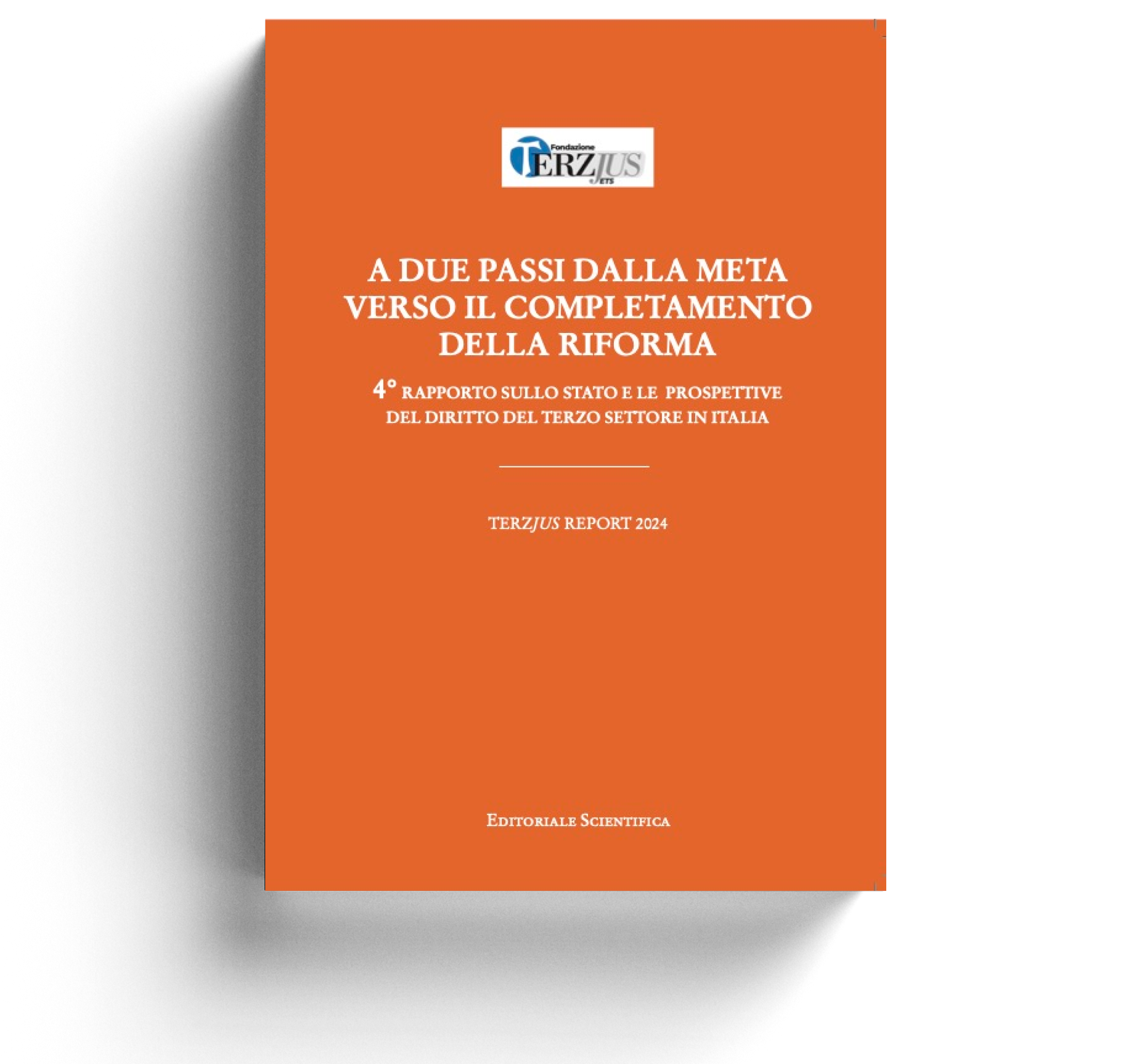Con l’abstract di Claudio Gagliardi, prosegue la pubblicazione settimanale delle sintesi dei capitoli del Terzjus Report 2024.
di C. Gagliardi, “Gli enti dell’economia sociale dal registro delle imprese: settori di attività, impatto occupazionale e competenze”, in A due passi dalla meta. Verso il completamento della riforma. Quarto rapporto sullo stato e le prospettive del diritto del terzo settore in Italia, Cap VI, pagg. 257-279, Editoriale Scientifica, Napoli 2025.
Nel suo Rapporto sul futuro della competitività europea Mario Draghi ha sottolineato che gli Stati Uniti si trovano oggi in una posizione competitiva più favorevole rispetto all’Unione Europea, soprattutto grazie ai grandi investimenti fatti nelle nuove tecnologie, registrando però, d’altra parte, una forte crescita dei tassi di disuguaglianza. Invece il “modello europeo” potrà affrontare le sfide senza precedenti che ha davanti sul piano geopolitico e della competitività globale solo riuscendo a garantire che gli investimenti necessari per far crescere la produttività mantengano intatto il tessuto sociale. La crescita delle competenze dovrà andare di pari passo con l’inclusione sociale e con la partecipazione attiva delle persone nei percorsi di transizione professionale, soprattutto considerando il quadro demografico che nei prossimi anni vedrà diminuire drasticamente la popolazione in età lavorativa.
Se coesione sociale e competitività economica sono per la nostra cultura due facce della stessa medaglia, allora il mondo dell’economia sociale e il terzo settore rappresentano pilastri strategici senza i quali il “modello europeo” non regge. Per questo è di grande attualità la Raccomandazione del Consiglio europeo del 27 novembre 2023 attraverso la quale si richiede agli Stati membri di promuovere quadri giuridici e misure in favore dell’economia sociale. Partendo, anzitutto, dal presupposto che i soggetti dell’economia sociale mettono al centro le persone e sono capaci di creare e mantenere posti di lavoro di qualità, contribuendo all’inclusione sociale ed a pari opportunità per tutti. Questi enti sono importanti perché stimolano uno sviluppo economico sostenibile in una pluralità di settori produttivi e la partecipazione attiva dei cittadini nelle rispettive comunità locali.
Ma quali sono oggi, concretamente, i soggetti dell’economia sociale in Italia?
La definizione dell’economia sociale rappresenta, in effetti, una questione ancora dibattuta. In ogni caso, allo stato attuale, il punto di riferimento condiviso a livello europeo per l’individuazione degli attori e del “perimetro” dell’economia sociale è ben sintetizzato nelle definizioni e nei criteri adottati con la Raccomandazione del Consiglio UE, laddove si dice che rientrano nell’economia sociale un insieme di soggetti di diritto privato che forniscono beni e servizi ai propri membri o alla società, tra cui rientrano forme organizzative quali cooperative, società mutualistiche, associazioni, fondazioni, imprese sociali e altre forme giuridiche che operano seguendo alcuni principi: il primato della persona e della finalità sociale e/o ambientale dell’attività, rispetto al profitto; la destinazione “sociale” degli eventuali utili conseguiti; la governance democratica e partecipativa.
Rispettando questi principi possono rientrare tra i soggetti dell’economia sociale sia organizzazioni imprenditoriali che organizzazioni non imprenditoriali e, in generale, gli enti del terzo settore. Il perimetro risulta, evidentemente, più ampio rispetto a quello definito in Italia con il D.Lgs. 117/2017 e perciò appare opportuno un intervento legislativo che consenta di individuare con sufficiente chiarezza i soggetti dell’economia sociale per i quali promuovere politiche di sviluppo nel contesto nazionale.
Per definire, riconoscere e sostenere i soggetti dell’economia sociale – come viene raccomandato, oltre che dall’UE, anche da importanti istituzioni internazionali quali ONU, OCSE e ILO – è evidentemente fondamentale disporre di informazioni statistiche che consentano di individuare e monitorare nel tempo, in maniera affidabile, caratteristiche e diffusione degli enti che la compongono, l’impatto occupazionale che essi generano sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, le attività che realizzano.
Un contributo per una conoscenza più approfondita del quadro italiano dell’economia sociale viene offerto nel capitolo del Rapporto Terzjus 2024 dedicato agli enti dell’economia sociale iscritti all’interno del Registro delle imprese delle Camere di Commercio italiane. Questo tipo di analisi, basata su un’anagrafe amministrativa nazionale aggiornata per legge in “tempo reale”, ha il vantaggio di consentire anche per il futuro il monitoraggio sistematico e tempestivo di stock e flussi riguardanti oltre l’80% dell’occupazione generata nell’economia sociale.
Nei registri camerali, infatti, si contano complessivamente 54.100 enti dell’economia sociale con 1.226.270 lavoratori dipendenti. In particolare, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali) danno occupazione a 499.650 dipendenti, le cooperative (diverse dalle cooperative sociali) occupano 560.910 dipendenti; le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi e le società di mutuo soccorso danno lavoro a 165.710 dipendenti.
Considerando l’insieme dei settori industriali e terziari in cui operano, i soggetti dell’economia sociale hanno un peso corrispondente ad oltre il 9,1% dello stock dei dipendenti rilevato dall’Istat attraverso l’Archivio Statistico delle Imprese Attive nei settori extra-agricoli. E soprattutto nelle aree interne del paese, dove pesano per il 9,6% dei dipendenti, essi rappresentano spesso l’unica garanzia a disposizione della popolazione più fragile per accedere a servizi essenziali.
In alcuni ambiti, poi, tali enti diventano largamente maggioritari, come nel caso dell’assistenza sociale non residenziale, dove rappresentano quasi il 90% dell’occupazione o in quello dell’assistenza sociale residenziale dove superano il 70%. Ma anche nei settori dell’istruzione e della sanità il rapporto tra occupazione dell’economia sociale e occupazione privata totale è molto significativo, toccando rispettivamente quota 38% e 21%.
Se dall’analisi degli stock si passa a quella sui flussi, l’economia sociale si conferma straordinariamente capace di generare nuove opportunità occupazionali: sulla base dei dati del Sistema Informativo Excelsior (fonte Unioncamere-Ministero del Lavoro) sono state, infatti, oltre 564.000 le assunzioni programmate nel solo anno 2023 da imprese sociali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti religiosi e società di mutuo soccorso iscritti nei registri delle Camere di Commercio.
Si tratta, in generale, di una domanda occupazionale caratterizzata da elevata qualità (prevalenza di professioni high-skill), inclusività e pari opportunità, con quote molto più elevate rispetto alla media delle imprese profit per occupazione di laureati, donne, lavoratori stranieri e lavoratori svantaggiati.
Gli enti dell’economia sociale stanno, inoltre, svolgendo un ruolo importante nella sfida dell’inclusione sociale e professionale collegata alla transizione digitale. Accelerano, infatti, gli investimenti nelle diverse tecnologie digitali (lo dichiara il 73% delle organizzazioni, con percentuali ancora più elevate nella sanità, nella formazione e nell’assistenza sociale non residenziale) e si ricercano competenze informatiche anche avanzate per quasi la metà delle loro assunzioni. Anche la transizione green rende sempre più protagonisti nelle diverse comunità locali gli enti dell’economia sociale. Si tratta tipicamente di opportunità generate nell’ambito della produzione e distribuzione di energie rinnovabili e di quelle relative all’economia circolare. Le competenze green sono ritenute, quindi, necessarie – con diversi gradi di specializzazione – per il 72% delle assunzioni programmate da questi enti.
La capacità di coniugare in una pluralità di settori produttivi iniziative economiche innovative, sostenibilità, occupazione, crescita delle competenze e coesione sociale rende ormai gli enti dell’economia sociale una leva di straordinarie potenzialità a disposizione della politica economica (e non solo per i servizi di welfare). In questo senso va sottolineato la particolare dinamicità del mondo delle imprese sociali che rappresentano in Italia più del 32% delle organizzazioni e oltre il 40% dell’occupazione nell’economia sociale. A sei anni dal D.Lgs. 112/2017 si può rilevare che il 23,2% delle imprese sociali con dipendenti è “giovane” essendo nate dopo la riforma e per quasi un terzo le nuove imprese sociali prendono la forma di società di capitali, associazioni, fondazioni, cooperative diverse dalle cooperative sociali. Le cooperative sociali sono ancora largamente maggioritarie (90%), ma si sta consolidando il quadro di un crescente pluralismo organizzativo e societario all’interno della “galassia” delle imprese sociali. E aumentano anche i settori economici in cui operano. La principale (anche se non unica) tipologia di ente del terzo settore prevista nell’ordinamento italiano per lo svolgimento di un’attività d’impresa di interesse generale, si dimostra così sempre più flessibile e capace di generare un impatto sociale ed economico positivo sui territori.
Le grandi potenzialità dell’economia sociale non sono però ancora adeguatamente riconosciute e valorizzate nel nostro paese. Il Piano d’azione Nazionale per l’economia sociale che entro novembre 2025 dovrà essere definito dal Governo italiano, potrà consentire di affrontare, nel dialogo tra i diversi attori, le criticità ancora esistenti e creare un contesto normativo e di sviluppo favorevole.
Per dare forza all’economia sociale servirà, soprattutto, il coinvolgimento dei territori dove possono prendere corpo forme di progettazione in condivisione e partenariato tra settore pubblico e settore privato, tra enti del terzo settore e imprese profit, piattaforme per agevolare l’accesso ai finanziamenti e accompagnare la valutazione, il monitoraggio e l’attuazione delle strategie di promozione dell’economia sociale. Per questo sarà importante l’organizzazione di osservatori territoriali e comitati di coordinamento con il coinvolgimento attivo della cooperazione e degli enti del terzo settore, degli enti locali, delle università, dei rappresentanti delle economie locali e delle camere di commercio.