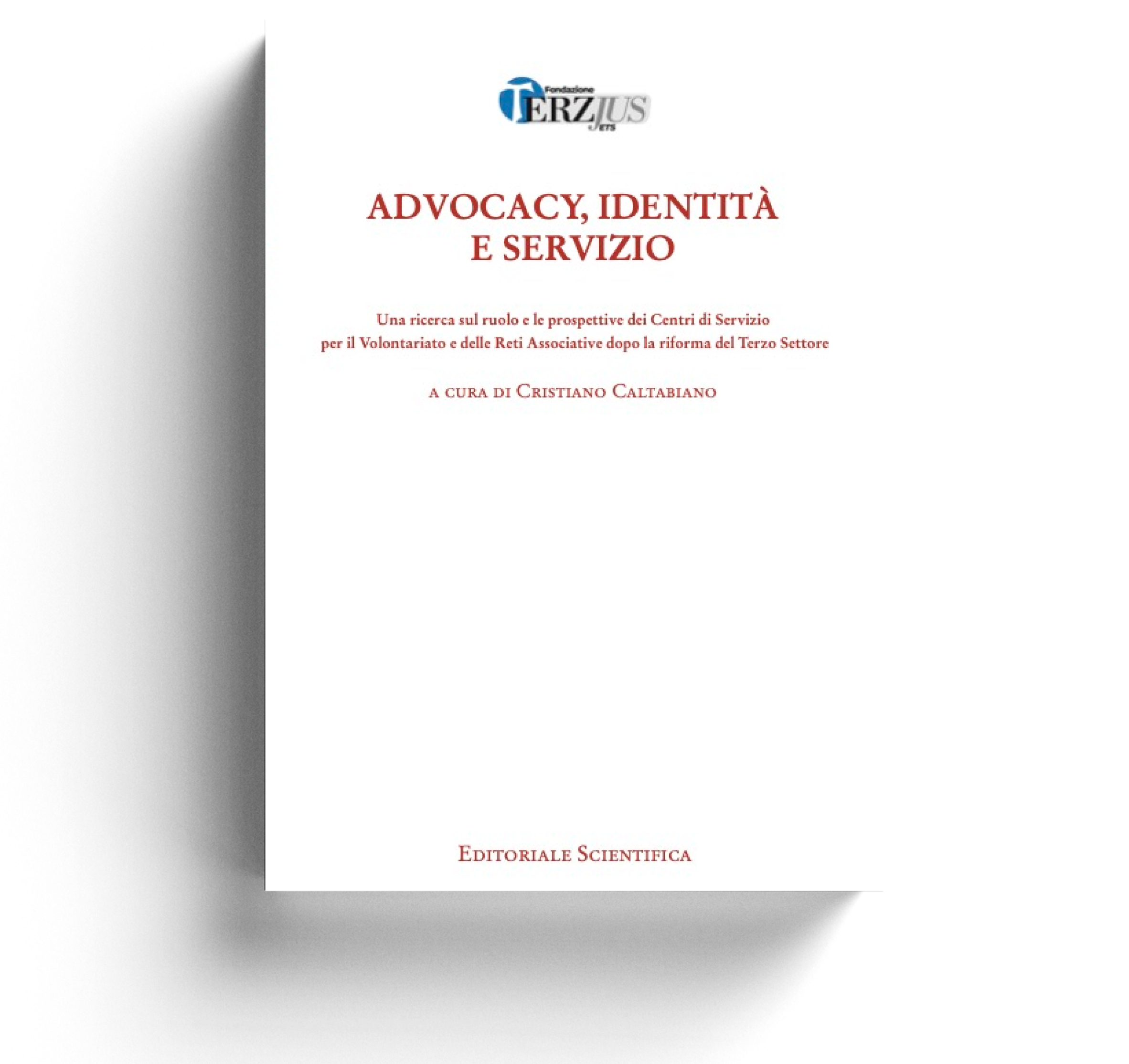Luigi Bobba, “Conclusioni” al volume Advocacy, identità e servizio, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, pagg. 279-283
1. Premessa
Questo lavoro di ricerca – unico nel suo genere – cerca di ricostruire, con un’analisi di tipo qualitativo, le trasformazioni intervenute dopo la riforma del Terzo settore sia nelle Reti Associative (RA), sia nei Centri si servizio per il volontariato (CSV). Si tratta di due realtà che non sono originate da quanto previsto – in modo puntuale e distinto – dal Codice del terzo settore (CTS); bensì di soggetti che hanno avuto – le RA – un esplicito riconoscimento nel CTS; o che sono stati interessati – i CSV – da un sostanziale processo di riorganizzazione disciplinato proprio dagli articoli 61-66 dello stesso CTS. Di qui l’idea, nell’ambito di un lavoro di formazione/ricerca commissionato da Unioncamere alla Fondazione Terzjus, di comprendere in modo più approfondito le dinamiche e i cambiamenti intervenuti negli anni post Riforma per le RA e per i CSV. Infatti, la Riforma – pur con caratteri nettamente distintivi per i due diversi soggetti – ha immaginato e previsto un ruolo di catalizzatori del variegato mondo degli ETS nonché di attivatori dei processi regolativi e promozionali della stessa. Dall’insieme di questo report, si coglie un certo “dinamismo” con cui sia le RA sia i CSV hanno interpretato e valorizzato il ruolo e le distinte funzioni che il CTS assegna a loro.
2. Le Reti Associative: tra rappresentanza, advocacy e costruzione dell’identità
Le RA non sono certo nate con il CTS, ma per la prima volta vengono giuridicamente normate e riconosciute attraverso una procedura pubblica e trasparente. Per di più sono loro attribuite specifiche e distintive funzioni (si pensi alla possibilità di elaborare statuti-tipo da far validare dal MLPS per poi avvalersene per tutta la propria rete) fino a poter esercitare – in presenza di specifici requisiti – anche funzioni pubbliche come quelle di monitoraggio e controllo sui propri affiliati. Inoltre, la funzione di rappresentanza viene altresì amplificata e rafforzata mediante il riconoscimento, a livello nazionale, da parte del MLPS del soggetto maggiormente rappresentativo, che – come è noto – è stato in questi anni sempre identificato nel Forum nazionale del Terzo Settore, che si presenta dunque come una rete delle reti, diventando così un interlocutore privilegiato non solo del Governo ma anche di altri soggetti istituzionali e non. Il fatto che alla fine di aprile 2025 – vi siano 58 Reti riconosciute dal MLPS e regolarmente iscritte al RUNTS, dice che l’obiettivo del legislatore sia stato in parte già conseguito. Non solo, si ha notizia che diverse altre realtà stanno lavorando per dare forma compiuta al processo di organizzazione anche formale della propria rete, finora esistente spesso con caratteri di coordinamento meramente informale. Ciò consentirà alle stesse di potersi iscrivere al Registro e di accedere ai benefici e alle risorse destinate specificamente alle RA. Più in specifico, le RA si sono caratterizzate – anche nel tempo della pandemia – sia nel tenere insieme e nel dare impulso ad una realtà multiforme di piccole associazioni poco strutturate e poco professionalizzate ma alquanto radicate nelle comunità locali; sia nell’offrire una rete di servizi di sostegno e promozionali per assecondarne nel tempo la tenuta e la crescita. Rafforzare e alimentare l’identità comune e mettersi al servizio dei propri affiliati sono state le linee guida di molte delle 58 RA oggi riconosciute (si veda in proposito il contributo di Cristiano Caltabiano nel primo cap. di questo volume). A ciò si aggiunga – e questa è una specificità esclusiva delle RA – la capacità di promuovere una rappresentanza qualificata degli interessi dei propri associati presso le istituzioni locali e nazionali e di intessere rapporti collaborativi con le imprese profit anche al fine di raccogliere risorse per i progetti più innovativi, nonché di avviare campagne di mobilitazione – sia come singole reti ma anche e più in particolare insieme al Forum nazionale del Terzo Settore – su tematiche e problematiche che non hanno voce e attenzione nel dibattito pubblico. Dare “voce” a domande e bisogni inespressi significa sottrarre all’invisibilità persone, gruppi sociali e territori che rischiano di essere quasi del tutto dimenticati. È questa una funzione oggi particolarmente rilevante, considerata la scarsa capacità dei rappresentanti politici e sindacali, di individuare i bisogni delle persone e dei territori più vulnerabili per incanalare in un alveo istituzionale domande che altrimenti resterebbero a lungo senza alcuna risposta, alimentando così il perverso circuito delle diseguaglianze. Una funzione che ridisegna i luoghi della rappresentanza democratica, colmando uno iato sempre più profondo tra cittadini e istituzioni; iato che finisce per rendere sterili o per lo meno fragili i processi di partecipazione democratica.
3. I CSV: agenti di sviluppo del volontariato
Anche i CSV non sono nati con la riforma del Terzo settore. Come è noto, la loro origine risale alla l. 266/91 che ha disciplinato queste strutture di servizio al fine di sostenere, accompagnare e qualificare la crescita e lo sviluppo delle ODV. La stessa legge ha disposto uno specifico finanziamento dei CSV attingendo ad una quota delle rendite finanziarie delle Fondazioni di origine bancaria. Il CTS, senza abrogare la precedente normativa, ha operato un sostanziale riordino dei CSV e attribuito agli stessi nuove funzioni; in particolare, è stato rivisto il sistema di controllo, la platea dei soggetti che possono afferire ai CSV, ma soprattutto è stato ridefinito il campo di azione. I CSV non sono più solo destinati a supportare le ODV, ma a promuovere il volontariato in tutti i soggetti (escluse le imprese sociali in forma societaria) che assumono la qualifica di ETS. I CSV, come si evince sia dall’analisi condotta in questo report da Massimo Lori, sia dai quattro studi di caso, mirano a legare – in particolare con attività di promozione e servizio – le realtà minori in special modo appartenenti al mondo delle ODV, che si presenta meno strutturato in grandi RA nazionali. Infatti delle 58 RA riconosciute, più del 70% appartengono al mondo delle APS e solo una piccola parte invece fa riferimento alle organizzazioni di volontariato. Questa diversa conformazione organizzativa rende più evidente la necessità per le migliaia di piccole associazioni di volontariato di trovare sul territorio delle strutture di servizio e di promozione in grado di rispondere ai loro bisogni e di accompagnarle altresì nel processo di nuova regolazione che la riforma del terzo settore ha comportato. Non di meno, le compagini associative dei 49 CSV territoriali si stanno gradualmente aprendo alle nuove realtà che sono nate dopo la riforma, interpretando così in modo positivo l’orientamento del legislatore. Ma la novità più rilevante è rappresentata dallo spostamento, nel periodo post-riforma, di attenzione e risorse verso le attività formative e promozionali sul territorio al fine di incoraggiare e motivare le persone ad impegnarsi nelle molteplici realtà associative locali. Non solo servizi tecnici e informazione, ma attività volte a far incontrare le disponibilità di singoli cittadini all’impegno civico e volontario, con le organizzazioni presenti sul territorio. Anche il lavoro di riordino e accorpamento dei CSV – operato dalla Riforma – sembra aver meglio indirizzato le risorse messe a disposizione, anche con una quota proveniente dal bilancio dello Stato, di questi “facilitatori” territoriali dell’azione volontaria. I CSV, stanno man mano assumendo il ruolo di intermediari tra singoli cittadini o piccoli gruppi informali e le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, interpretando così un bisogno emergente di trovare nella propria comunità un luogo, un’occasione per poter esprimere al meglio la propria disponibilità all’impegno volontario. Gli incontri nelle scuole, la promozione del servizio civile diventano così l’occasione per avvicinare e motivare generazioni più giovani all’azione volontaria. È ben vero che il modello di servizio e promozione messo in atto dai 49 CSV non è uniforme su tutto il territorio nazionale, pur avendo come riferimento una normativa unitaria; ma le specificità territoriali, se non diventano un vettore di frammentazione e se trovano un luogo di confronto e indirizzo nell’associazione nazionale – CSVnet – possono rappresentare una risorsa per meglio aderire ai bisogni delle comunità locali.
4. Le sfide comuni
Da tutto il lavoro svolto, risultano ben chiare le specificità e le diversità che caratterizzano le RA e i CSV. Ognuno di questi due grandi “facilitatori” dell’impegno civico e volontario deve cercare di svolgere al meglio il proprio compito non solo in coerenza con il dettato normativo, ma altresì rispondendo in modo efficace alle molteplici domande dei propri affiliati. Non di meno, anche in forza di questa pluralità, sia per le RA che per i CSV si presentano due sfide comuni che non possono essere ignorate o affrontate senza una qualche virtuosa convergenza di azione sul territorio: in primis, accompagnare i propri aderenti nel processo di attuazione della riforma, non solo per la parte di regolazione (quasi conclusa) ma soprattutto quella promozionale, meno conosciuta e ancora in gran parte inattuata. In secondo luogo, abilitare i singoli ETS nella capacità di attrarre nuove persone, volontari e lavoratori qualificati, sia per facilitare un ricambio generazionale, sia per poter disporre di risorse adeguate nel rispondere ai nuovi bisogni che si presentano nelle comunità. Circa la prima sfida, ora che il processo di regolazione è quasi completato e che gli ETS hanno in larga parte metabolizzato i nuovi adempimenti previsti dal Registro, viene il tempo di concentrare energie, risorse e progettualità per consentire a tutti gli ETS di cogliere appieno tutte le opportunità contenute nel CTS. Dalle diverse survey di RIM – Riforma in movimento –, si è potuto rilevare un graduale miglioramento da parte degli ETS nella conoscenza delle misure promozionali e, in parte, anche nella capacità di utilizzarle come opportunità di crescita e sviluppo. Non mancano però i segnali di difficoltà e vischiosità nel dare attuazione alle diverse misure promozionali. Ad esempio, mentre si registra una crescita sensibile degli ETS beneficiari del 5 per 1000 (più 8.700 tra il 2022 e il 2023), crescono anche gli ETS a “zero firme”, ovvero enti che non hanno trovato nemmeno un contribuente che abbia indicato il loro codice fiscale nella dichiarazione dei redditi. O ancora, la quota del tutto modesta di cittadini – anche con redditi medio-alti – che effettua donazioni per cui sono previsti incentivi fiscali mediante detrazioni o deduzioni; per non parlare dei pochi progetti finora presentati per l’utilizzo del social bonus o, infine, al numero, certamente cresciuto ma ancora non così rilevante, di esperienze di amministrazione condivisa. Non è infondato affermare che solo una decisa torsione dell’azione di RA e CSV potrà produrre un salto di qualità nell’azione promozionale. Ciò significa che, (per fare qualche esempio) se iscrivendosi al RUNTS, divento potenzialmente beneficiario del 5 per 1000, poi dovrò necessariamente mettere in campo un’azione promozionale per cercare di orientare quel circa 60% di contribuenti, che ancora non destinano il proprio 5 per 1000, a considerare non solo l’opzione ma anche a finalizzarla alla mia organizzazione. Oppure, promuovere adeguate campagne di raccolta fondi spingendo sulla leva della generosità, sostenuta anche da adeguati incentivi fiscali. O ancora, diventare soggetti proattivi nel proporre alla Amministrazione del proprio territorio l’avvio di una procedura di coprogettazione finalizzata a rispondere ad una domanda insoluta della propria comunità; o magari di concedere in comodato gratuito ad un ETS un bene pubblico inutilizzato o confiscato ai poteri malavitosi per destinarlo ad una nuova attività o servizio di interesse generale. È evidente che questo richiede un cambiamento di cultura, di modelli organizzativi non solo per la PA, ma proprio per gli ETS. E le Reti e i CSV possono essere degli attivatori di processi di utilizzo virtuoso delle opportunità e delle risorse messe a disposizione dalla riforma. In secondo luogo, anche mediante il sostegno delle fondazioni bancarie e filantropiche, le RA e i CSV potrebbero accompagnare e sostenere gli ETS a loro aderenti nell’affrontare la principale criticità che essi stessi denunciano. Ci si riferisce alla difficoltà nell’attrarre sia nuovi volontari sia risorse professionali qualificate. Intercettare il volontariato individuale, fluido, discontinuo e attrarre giovani talenti per i progetti più impegnativi e sfidanti, è compito inedito che le singole organizzazioni, specialmente le più piccole, non sono in grado di affrontare. Da qui l’urgenza che non siano lasciate sole a vivere questa difficile transizione. RA e CSV, anche sollecitando la messa a disposizione di risorse finanziare da parte delle Fondazioni bancarie, possono creare le condizioni per rafforzare la strutture dei propri associati, non imprigionarli in attività progettuali di breve periodo e orientarle, invece, ad assumere come priorità la rigenerazione del loro capitale sociale, intercettando e trattenendo sia nuovi volontari, sia risorse lavorative motivate a restare nei circuiti associativi per investire lì le proprie capacità professionali anche di alto livello. Facilitare e rendere fluido il ricambio generazionale dei gruppi dirigenti degli ETS, oggi in gran parte di età adulto/anziana e provare ad intercettare il volontariato giovanile assai più fluido di un tempo, oltre che il net-attivismo rappresentano certamente le sfide più impegnative di questo tempo.